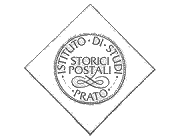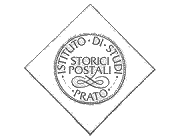|
Dieci relatori di
differente estrazione hanno sottoposto dieci temi legati fra loro da un
solo filo conduttore: “Posta e tecnologia”. Si è svolto sabato
all’Archivio di stato di Prato il quarto colloquio firmato
dall’Istituto. Intanto, già si lavora sulle prossime iniziative...
Prato (26 febbraio 2007) – Tanti argomenti densi, ognuno
“toccato” in appena quindici minuti. Dieci, tra studiosi ed
appassionati, gli esperti che si sono alternati al tavolo dei relatori
sabato 24 febbraio per il quarto Colloquio di storia postale, voluto
dall’Istituto di studi storici postali. Patrocinato da Comune e
Provincia, è stato ospitato all’Archivio di stato cittadino e si è
concentrato su “Posta e tecnologia”.
“Un incontro che ha permesso -spiega a bocce ferme il direttore dell’Issp,
Andrea Giuntini- di avvicinare due mondi, quello scientifico e
quello collezionistico. Mondi che spesso procedono in parallelo, con
strumenti, fonti e metodologie diverse. Hanno però in comune
l’argomento: la posta e come si è sviluppata nel tempo. Questa volta
abbiamo voluto porre l’accento sugli aspetti tecnologici tra Ottocento e
Novecento”.
Archiviato l’incontro, l’Istituto –attivo ormai da un quarto di secolo-
guarda avanti. A marzo sarà a Parigi per i dieci anni del Comité de l’histoire
de la poste. Nello stesso mese verrà illustrato a Roma il progetto
portato avanti con l’Anas e dedicato alle strade della posta. Altre
iniziative si presentano per giugno a San Marino (la Repubblica
celebrerà i quattro secoli del postiglione) e poi in ottobre a Prato con
il quinto seminario “Scrittura e comunicazione”. Senza naturalmente
dimenticare le attività ordinarie, come la rivista ed il costante
sviluppo del patrimonio librario a disposizione pubblica. “L’Istituto
–ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Prato, Andrea
Mazzoni- è una delle strutture che corroborano l’attività culturale
di Prato, ne tiene alto il nome in questo settore specifico, offrendo
centinaia di migliaia di documenti, 12mila libri, 1.200 testate
periodiche, un sito oggi più accattivante, attività editoriale, mostre.
Insomma, ha un’attività vivace”.
Le relazioni in sintesi
Ad avviare gli interventi, organizzati in ordine cronologico secondo il
tema, è stato Armando Serra, che si è concentrato su “Il
progresso delle sospensioni delle carrozze di posta negli inventari
ippopostali della prima metà dell'Ottocento”. La ricerca d’archivio è
fondata sui registri romagnoli risalenti alla prima metà del XIX secolo,
riguardanti il passaggio della proprietà da un operatore all’altro.
Statisticamente, il 67% del patrimonio è rappresentato dai cavalli, il
21% dalle vetture ed il restante 17% da altri beni, come finimenti ed
attrezzi.
Secondo Marcello Manelli, che ha parlato de “La sicurezza
antifalsificazione nei francobolli italiani”, il francobollo è un
condensato di tecnica ed estetica e l’interesse per le tecniche
antifrode si è rivelato ampio, fin dall’inizio. “A fine Ottocento –ha
precisato- i nostri tecnici furono tanti bravi da annullare ogni
falsificazione”. Accanto alla filigrana, vi sono altri accorgimenti,
come la carta costolata (in uso nel Lombardo Veneto fin dal 1850) o i
fili di seta (nel Regno Unito dal 1867). Oggi la preoccupazione non è
più così evidente, anche se i casi di falsi non mancano.
Dalla posta alle telecomunicazioni con Simone Fari, che ha
preferito il tema “La standardizzazione tecnologica della telegrafia
dopo l'Unità d'Italia”. Con il 1889 telegrafi e poste, in tutta Europa,
sono andati di pari passo, ma occorreva trovare degli standard comuni.
Tipico è il caso dell’Italia, che nel 1861 si è trovata a riunificare
sette stati e otto reti telegrafiche. La selezione ha fatto in modo di
prediligere economicità e praticità di impiego, per cui a primeggiare,
rispetto ad altri sistemi, è stato il telegrafo di tipo Morse, con testo
scritto e congegni molto semplici da riparare. Scelta restata operativa
ufficialmente fino al 1993.
Nato per far avere i soldi ai soldati napoleonici schierati in tutta
Europa, il vaglia è stato poi adattato anche agli usi civili. Valter
Astolfi, nel suo intervento “L’introduzione del vaglia telegrafico
in Italia”, ha spiegato le procedure affinché il denaro fosse trasmesso,
con tutte le cautele, al beneficiario. Il vaglia telegrafico è stato
adottato dalla Svizzera nel 1864, l’anno successivo dall’Italia. Un
accenno, per il suo interesse sociale, è stato dato al capitolo dei
vaglia consolari, ideati per favorire le rimesse degli emigrati.
“Noi collezionisti –ha detto Mario Pozzati, intervenendo per «La
tecnologia negli uffici e nelle bollatrici»- ci concentriamo sull’orma,
ad esempio sul timbro. Ma spesso perdiamo di vista quanto c’è dietro,
nel caso specifico le operazioni di timbratura”. Tenendo presente che il
vero terrore delle poste, una volta, era l’impiego del francobollo già
usato. Partito dai primi progetti ottocenteschi di macchina timbratrice,
l’esperto ha effettuato una carrellata dell’esperienza, soprattutto
nazionale, in materia.
Mario Coglitore è un ricercatore, che sta studiando i fascicoli
del personale impegnato alle poste fino al 1950. Fascicoli definiti “una
miniera di informazioni”, dai quali trapelano vicende interessanti. Ad
esempio quella che ha motivato l’intervento “Impiegato e inventore: la
bollatrice di Michele Bertorello. Storia di una passione”. Bertorello,
classe 1875, ha lavorato in uffici a grande movimento ed è per questo
che è stato stimolato nel cercare di risolvere i problemi quotidiani.
Nel 1910 progetta una macchina a mano, o a motore, per timbrare 300
plichi all’ora, ma anche quando va in pensione (nel 1946) chiede,
invano, di ritornare in ufficio. Ancora a 72 anni suggerisce una
macchina per chiudere i dispacci.
Enrico Bertazzoli si è soffermato su un altro ambito,
sintetizzato con “Lo sviluppo dell’affrancatura meccanica”. Brevettata
dall’italiano Detalmo Savorgnan di Brazzà nel 1896, solo vent’anni dopo
si è realmente diffusa. In Italia è stata introdotta nel 1927 e già
l’anno successivo si contano 150 utenti, principalmente banche,
assicurazioni ed enti. Nonostante il periodo relativamente breve, la
produzione nazionale “è tra le più complesse al mondo”, con molto
operatori e molti modelli. Oggi si stimano in 60-70mila le macchine
esistenti, realizzate da quattro aziende. Nel 2004 si è registrato un
ulteriore passo, con il collegamento speruimentale in remoto.
“Gli uffici postali particolari” è il titolo della testimonianza portata
da Alcide Sortino. Ha parlato dei servizi sui treni, cioè degli
ambulanti, poi di quelli sulle navi, i natanti (in Italia l’esempio più
significativo è il Napoli-Palermo, che smistava a bordo il corriere).
Altre le vicende che hanno caratterizzato i recapiti -di iniziativa
privata- presso magazzini commerciali, enti, ministeri, grandi e medie
aziende. “Vanno e vengono”, a seconda della politica del personale
seguita al ministero.
Tre, secondo Giorgio Chianetta, che ha proposto “La
meccanizzazione dagli anni Cinquanta”, le fasi caratterizzanti lo
smistamento della corrispondenza: la prima è grossolana (ora si basa
sulle cifre iniziali del codice di avviamento), la secondo più raffinata
(si considera la via), la terza è la finale, quella meno meccanizzabile,
svolta dal portalettere. Di progetti per la suddivisione del corriere si
parla sin dal 1840 e Chianetta ha sintetizzato gli sforzi effettuati
presso i Paesi più significativi. Solo in Italia nel 2004 sono stati
trattati sette miliardi di oggetti: la tecnologia “deve aiutare e far
risparmiare i costi”, incidendo dunque sul numero dei posti di lavoro.
Occorre andare oltre le carte valori tradizionali, di fatto superate dai
tempi. Giovanni Riggi di Numana, con “I recenti sistemi che
sostituiscono il francobollo”, ha puntato il dito sulle varie procedure
che negli ultimi anni hanno stravolto l’ambiente. L’elettronica, almeno
in Italia, ha cominciato ad essere impiegata tra 1994 e 1995; nello
stesso tempo il ministero è stato ristrutturato, portando a Poste
italiane spa. È un percorso ancora in fase di sviluppo, tutto da
studiare: vi sono aziende che intervengono e che poi escono dal mercato,
procedimenti tecnici introdotti in via sperimentale e poi cancellati,
altri che invece funzionano e restano. Contemporaneamente, occorre fare
i conti con le norme e il marketing.
servizio
stampa e comunicazione:
Fabio Bonacina, mail
fabio.bonacina@libero.it
|