
varietà in filatelia
| Tweet | |
varietà in filatelia
difetti e mancate rarità
di Giuseppe PREZIOSI (da l'Occhio di Arechi n. 40)
Questa volta non sono stato fortunato! Le altre volte il lavaggio di tanti francobolli uguali mi ha consentito di individuare difetti, varietà e comunque diversità che hanno permesso l'arricchimento delle mie raccolte. Stavolta, invece, un'autentica varietà si è letteralmente dissolta sotto i miei occhi senza che neanche me ne accorgessi.

A saperlo!! Ma posso garantirlo, a occhi nudi e senza neanche sospettare
quel che sarebbe successo era praticamente impossibile prevedere che un
francobollo potesse svanire nell'acqua come e peggio dei gatti del 1993.
Solo che con la serie dei felini si era detto e ripetuto che un uso
sbagliato del fissativo (o come dice il "Sassone": un difetto di ancoraggio
degli inchiostri sulla superficie dei fogli di stampa) aveva provocato il
disastro (che peraltro tra le mie mani non si è mai verificato). Per questo
modesto, modestissimo francobollo, invece, nessuno ha mai segnalato una tale
possibilità semplicemente perché…. Non era possibile. E ciò peraltro riapre
il discorso sul tipo di carta attualmente usata al Poligrafico e sui vari
passaggi di stampa, gommatura e perforatura di fogli. É anche vero che
l'indagine può apparire obsoleta oggi che la gran massa della produzione di
francobolli si fa su carta speciale pretrattata, autoadesiva, su supporto
siliconato, ma sino a due anni fa quello che è emerso sarebbe stato di
grandissima attualità.
Il modestissimo francobollo senza immagine di cui qui tratto è uno dei tre
milioni e mezzo di pezzi dedicati al centenario della Targa Florio, emesso
il 6 maggio 2006, solo cinque anni e mezzo or sono, che appare da un lato
completamente bianco, mentre dall'altro ha conservato un minuscolo frammento
di colore che a stento ne consente l'identificazione.

Ma procediamo con
ordine. Il pezzo di cui sto raccontando la storia fa parte di alcune grosse
partite di frammenti usati provenienti dal Nord e da me già suddivisi, per
formato, in blocchi da 100 per il lavaggio. Probabilmente fu lo stesso anno
di emissione o quello immediatamente successivo. Fino ad oggi, dopo il
lavaggio, la fase successiva ha previsto sempre una drastica selezione per
eliminare pezzi rotti o difettosi. Tra l'altro, in un mio articoletto
apparso sul n. 78 dell'Informazione del Collezionista, avevo addossato una
parte della colpa per pieghe e strappi dei francobolli alle macchine
bollatrici utilizzate da Poste Italiane nei CMP, ricevendo tra l'altro un
affettuoso rabbuffo dal Dott. Vieschi, ultimo direttore delle vecchie PPTT
che peraltro stimo moltissimo.
La mia attenzione è stata quindi sempre rivolta all'aliquota di difettosità
tra i francobolli e soprattutto alla tipologia dei difetti. Purtroppo, da
oltre 10 anni, ho notato che la qualità della carta è peggiorata, almeno per
quanto riguarda lo strappo lungo la dentellatura.
Cento anni fa a rendere disastrosa la qualità dei primi francobolli del
regno aveva provveduto una dentellatura approssimativa apposta su una carta
troppo sottile. Durante il Regno, dopo il 1929, la qualità della carta
migliorò di molto ed anche la dentellatura a blocco contribuì a ridurre la
difettosità che però crebbe per via di una certa arrendevolezza della carta
alle pieghe, soprattutto dei dentelli d'angolo. Dopo la II Guerra mondiale e
il periodo della carta scadente (che poi era grigiastra e piena di impurità
ma non da buttare via), con la filigrana ruota, la situazione ritornò al
1940, anzi la carta assunse una maggiore consistenza. Solo con il III tipo
della filigrana (e il I di quella a stelle) si ebbe il problema dello
strappo che generava francobolli difettosi dove i dentelli e la filigrana
coesistevano. In pratica il differente spessore della carta creava una
resistenza diversa alla trazione e quindi uno strappo irregolare. In un modo
più subdolo la situazione si è perpetuata attraverso gli altri tre tipi di
filigrana stelle che hanno generato, allo strappo, milioni di dentelli
"corti" ed "evanescenti". La carta non filigranata avrebbe dovuto risolvere
il problema rendendo più agevole lo strappo, visto che la tensione sulla
carta si sarebbe dovuta distribuire in modo uniforme. Ma fu proprio con la
carta non filigranata (e fluorescente), circa 45 anni fa, che cominciò un
nuovo tipo di problema legato alle varie "sperimentazioni" tese a conciliare
qualità, costi e soluzione di problemi tecnici di gommatura e stampa. In
questo lasso di tempo è successo di tutto: carte fragili, gessate o
patinate, con fluorescenza superficiale da vernice, o in pasta, con colle
viniliche più o meno resistenti, idrosolubili, alcool solubili o sensibili
alle spugnette da tavolo imbevute d'acqua (e di colla di altri francobolli).
Anche la dentellatura a pettine con "dentoni", riallineamenti automatici,
etc. ha favorito lo scadimento nella perfezione dei francobolli usati. Dal
2000 circa in poi, la carta ha subito ulteriori trasformazioni risultando
qualitativamente discutibile. Le fibre dell'impasto, in effetti, allineate
con un certo verso, nell'asciugarsi dopo il lavaggio, hanno mostrato la
tendenza a raggrinzire il francobollo creando un "effetto sigaretta"
diversamente marcato ma sempre visibile. Tale situazione è durata almeno
sino al 9 giugno del 2007 (emissione "Dolmen di Bisceglie") quando, e ignoro
se ciò sia stato segnalato da qualcun altro, la qualità della carta è di
nuovo mutata almeno per quanto riguarda i valori del cosiddetto formato
gigante. In effetti, al momento del lavaggio, le due carte risultano quasi
sempre distinguibili per via di un fenomeno di trasparenza: la carta
anteriore al giugno del 2007, bagnata, dà la possibilità di intravedere al
verso il disegno del recto. Quella posteriore alla data indicata è invece "mat"
ed ha certamente le fibre più spezzate, è quindi meno evidente l'"effetto
sigaretta". Ma non basta, anche la colla, per quanto simile non ha
un'identica tenacia. Quella apposta al retro dei francobolli "trasparenti"
lega molto di più le vignette alle buste tanto che lo scarto per difetti di
spellatura, anche poco visibili, è molto più elevato. Entrambi i tipi, però,
sembrano realizzati con due strati intimamente connessi. Il superiore è
molto levigato in entrambi (ancor più nel secondo), la curvatura della carta
perciò si presenta (molto più nel tipo "trasparente" che nel "mat") con la
gobba verso il lato stampato, quello cioè più levigato e quasi gessato.
Per quanto riguarda la facilità dei francobolli a "difettarsi" non vi è una
sostanziale differenza tra i due tipi di carta.





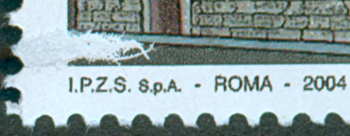


Archivio di Stato di Firenze (piega con strappo). Basilica di Parma (piega con bollatura al verso). Dolmen di Bisceglie (abrasione al recto con strappo). Filippo Lippi da € 0,45 (vistosa piega orizzontale). Gentile da Fabriano (doppia vistosa piega di cui una d’angolo). Festival della filatelia 2009 (Serie di dentelli verticali corti o mancanti). Università L.U.M.S.A. (abrasione al recto). Turistica: Massafra (Serie di dentelli orizzontali corti o mancanti). Tesoro di San Gennaro e Oratorio Santissima Annunziata (porzione, anche di un solo strato, dei francobolli confinanti).
Entrambi si strappano
molto male, con dentelli "corti" o "trasparenti". Entrambi si danneggiano
irrimediabilmente con una pur lieve piega che lascia una visibile traccia al
recto, entrambi perdono facilmente i dentelli d'angolo, entrambi portano
spesso con sé frammenti dei francobolli confinanti, spesso anche di un solo
strato della carta. Di fronte a tale situazione (e a tale discutibile
qualità) è già molto se lo scarto, fra difettosi e rotti, si attesta intorno
al 40 – 45%, un'enormità a paragone dei francobolli precedenti agli
esperimenti. Se proprio vogliamo fare una sottile distinzione potremmo
indicare una percentuale lievemente inferiore di scarto tra i francobolli
più recenti, rispetto a quelli del periodo 2000 – 2007 e ciò per via di un
numero inferiore di casi di spellatura al verso. Bisogna inoltre ricordare
che un'aliquota comunque alta di difetti (strappi, pieghe, spellature al
recto) viene generata dalle macchine bollatrice dei vari centri.
A questo punto però è opportuno ritornare al Poligrafico e al momento in cui
stamparono il già ricordato francobollo scomparso.
Tutto, secondo me, è cominciato quando una bobina di carta fu prelevata per
essere montata sui rulli di stampa e di trattamento con la vernice
interferenziale (quella che si vede controluce e sembra dorata) e con la
gommatura. Innanzitutto dobbiamo partire dal presupposto che la carta abbia
un diritto e un rovescio e che, per un errore di inserimento, la carta sia
stata montata invertita per cui la parte levigata è finita a rovescio ed ha
ricevuto la colla, quella più ruvida è stata sottoposta alla stampa (a
questo punto senza nessun fissativo del colore, è evidente). Che ciò sia
vero è provato da parecchi indizi: innanzitutto la curvatura delle fibre è
verso la parte levigata che non è quella su cui è rimasto attaccato il
minuscolo frammento di colore che ha permesso il riconoscimento
dell'emissione, la parte levigata, poi, presenta una leggera perdita di
patina superficiale su brevi tratti di superficie, fenomeno visibile solo
controluce ed imputabile alla colla. La risposta alla lampada di Wood e
piuttosto scarsa, il che farebbe propendere per una leggerissima
fluorescenza in pasta (se fosse stata "in vernice" la fluorescenza si
sarebbe presentata giallognola brillante sul lato di stampa).
A questo punto lo scenario è piuttosto complesso. O dobbiamo immaginare che,
contemporaneamente, la carta sia stata inserita a rovescio e il fissativo
superficiale del colore non sia stato dato forse perché la macchina non
rispondeva al tipo di carta (rovescio) su cui era stata effettuata la
stampa, oppure via sia un passaggio che mi sfugge. Di certo possiamo
affermare che la gommatura è una fase (quella pre finale) del processo di
stampa e che i grossi rotoli di carta devono essere inseriti con un certo
verso, sempre lo stesso, nelle rotative. Il che poi porta ad una successiva
considerazione: che l'errore potrebbe essere stato commesso in cartiera al
momento dell'arrotolamento della carta sul cilindro portante.
Il nostro pezzo è raro? Potrebbe esserlo sapendo con esattezza quante bobine
di carta sono necessarie per la stampa di tre milioni e mezzo di pezzi
formato gigante o anche quanti fogli da 25 francobolli si ricavano da una
bobina; certo alcune migliaia (se si ipotizzano 4000 fogli saremmo in
presenza di 100.000 pezzi con le stesse caratteristiche ossia il 2,86%
dell'intera tiratura).
È evidente che la dispersione di una varietà praticamente invisibile allo
stato di nuova appare altissima, mentre molto bassa è la percentuale dei
pezzi usati finiti nelle mani di collezionisti esperti.
Viste le domande che il caso pone e le scarse risposte che le mie modeste
letture hanno potuto fornire, c'è qualcuno tra i miei trenta lettori che può
suggerirmi spiegazioni?