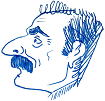|
|
| pagina iniziale | le rubriche | storia postale | filatelia | siti filatelici | indice per autori |
I - DALLE ORIGINI AL 1731
Nella seconda metà del seicento Roma era uno
dei punti nodali di un sistema di Corrieri Ordinari che congiungeva
tutta l'Europa, la Turchia e il Levante ottomano.
A Roma arrivavano i
Corrieri Ordinari di Genova, di Milano, di Venezia, di Spagna, di
Lione, l'ordinario e la staffetta di Napoli e il procaccio di Firenze.
Le Poste Pontificie erano altresì collegate con una staffetta con
Mantova e Ferrara.
La distribuzione o lo scambio della corrispondenza
trasportata dai Corrieri Esteri e diretta oltre Roma avveniva senza
conteggi. Giorgio Migliavacca dice che "la consegna (tra le poste
spagnole e quelle napoletane) avveniva il sabato notte: il
palafreniere della Segreteria degli Ambasciatori di Spagna in Roma
portava «grosse saccocce e quantità di lettere indirizzate verso la
città di Napoli e Regno" ai Ministri dell'Ufficio del Procaccio di
Napoli in Roma "senza emolumento alcuno» (nota 1).
Da un'altra fonte si ha
la conferma del sistema di pagamento per le lettere estere: «...Conviene
però avvertire che le lettere, e pieghi, che resteranno nella città,
ove passano gli Ordinari; potranno colà esser pagate; ma se dovranno
passare più oltre, sarà necessario pagarle dove si scrivono fino alla
città, dove le lasciano gli Ordinari; altrimenti non averanno
recapito: come per esempio; scrivendo da Roma per Polonia, l'Ordinario
lascia il piego a Praga, acciò indi sia inviato a' Polonia; e
l'Ordinario, che lo porta a Praga deve essere pagato da Roma fino a
Praga: quelli poi che ricevono le lettere, devono pagare da essa città
di Praga fino a Polonia, perché non pagandosi gli ordinari, le lettere
si perdono». (nota 2)
In Napoli e Sicilia le lettere "di fuori regno"
dovevano obbligatoriamente affrancarsi per il tragitto fino a Roma (nota 3).
Ne
consegue che per questo tipo di corrispondenza, con porto pagato fino
a Roma, non vi dovevano essere formalità per lo scambio tra le diverse
poste.
Tra la fine del 600 e i primi decenni del 700 il sistema dei
Corrieri Ordinari - che grosso modo possiamo identificare con gli
appaltatori dell'intero sistema postale - cambia e viene sostituito da
una gestione "statale" delle Poste e l'affitto a privati di singole
corse.
In questa cornice storica alcune poste europee acquisiscono il
diritto di tenere un proprio ufficio postale a Roma, e tra questi
anche la Posta napoletana. L'ufficio viene aperto nel 1731. (nota 4)
II - DAL 1731 AL 1806
Con l'apertura delle Poste estere non avvengono
cambiamenti nella struttura postale Pontificia che gestisce le poste
interne, e nei collegamenti "internazionali" espletati dalle poste dei
vari paesi.
Unica novità introdotta è la possibilità per le poste
estere di distribuire direttamente a Roma la corrispondenza che esse
trasportano.
In questo arco di tempo avviene un sostanziale
cambiamento nei rapporti postali tra le varie nazioni. Si instaura il
metodo di esigere un compenso a peso sulle lettere trasportate,
compenso che si aggiunge alla tassa pagata dal mittente. La Posta
ricevente doveva quindi pagare a quella immittente una certa cifra,
calcolata in base alla distanza. Il pagamento veniva effettuato col
sistema dell'accredito.
Il dare e l'avere veniva conteggiato a
scadenze fisse e la posta che risultava in debito compensava l'altra
con pagamento in denaro.
Vito Mancini parla di "sistema di baratto e
sistema di compravendita" (nota 5).
Io credo sia più giusto parlare di
accredito in quanto dal conteggio finale erano da calcolare le lettere indistribuite che ogni Posta restituiva all'altra e ne defalcava
l'importo dai conteggi.
È da notare che in tale attività non vi era
nessun intervento delle poste pontificie.
Ma... vi è un ma. Vi erano
delle poste che non cedevano le proprie lettere se non dietro
pagamento a pronta cassa.
E' il caso delle Poste di Francia chiaramente
delineato in una notificazione del 1741: «Essendosi veduto, che dal
non esservi reciproca corrispondenza tra gl'Offici di posta di questi
Regni, e dalla Francia in Roma nella consegna delle lettere, ne veniva
pregiudizio notabile al commercio, stanteché i Sudditi del Re Nostro
Signore non hanno colla regolar prestezza le lettere di Francia, le
quali o restano in quella Posta in Roma, o con maggior dispendio
devono i Particolari tenere colà persone salariate, che le piglino e
mettino a questa Posta di Sicilia: D'ordine di S.M., che con paterno
amore mira al bene de suoi Popoli, si è venuto a convenzione tra li
suddetti Officj di Posta di darsi reciprocamente dirette per li Dominj d'ambi li Monarchi, e pigliarle a quel prezzo, che si
dispenserebbero a Roma.» (nota 6).
Un gran passo avanti nelle relazioni
postali tra gli Stati, basata su due concetti rivoluzionari in quel
tempo:
1) le lettere venivano pagate in arrivo senza alcun onere per
il mittente;
2) La Francia e Napoli non avrebbero preteso nessun
compenso per il trasporto delle lettere fino a Roma.
Questa normativa
fa parte di un più ampio Trattato di reciproco commercio con la
Francia. (Fig.
1)
E' da notare che in questo periodo, che va dal 1730
al 1770 circa, né a Roma alle poste napoletane, né a Napoli per le
provenienze dalla Sicilia, venivano trascritte sulle lettere le tasse
pagate, almeno ciò è quanto si riscontra sulle poche lettere di questo
periodo che ho avuto occasione di vedere.
Anche in partenza non era
uso trascrivere sulla lettera la tassa pagata. Ne consegue che in
questo periodo è impossibile individuare la tassa effettivamente
pagata. (Fig.
2)
Dal 1760 circa vennero introdotti alcuni annulli di
provenienza "Genova", "Romagna", "Milano", "Venezia", "Germania" per
facilitare il computo delle tasse all'Ufficio del Corrier Maggiore, e
nello stesso tempo si cominciò ad apporre la tassa sulle lettere.
(Fig.
3)
Sul finire del secolo il metodo di tassazione non subisce
modifiche, mentre le tariffe vengono aumentate a grani 4 da Napoli a
Roma e a grani 9 siciliani da Palermo a Roma.
In questo arco di tempo
possiamo quindi desumere che lo scambio delle lettere a Roma avveniva
secondo i seguenti metodi:
a) scambio senza conteggi per le lettere
arrivate franche a Roma e per le lettere dirette in Francia (dal
1741);
b) scambio "a danaro" tra le varie Amministrazioni per le
lettere per le quali il paese cedente avanzava crediti di posta.
III - DAL 1806 AL 1816
La
posta napoletana a Roma viene chiusa nel febbraio 1806 con l'invasione
del regno di Napoli da parte dei francesi.
L'ufficio venne riaperto
nel 1808 e chiuso nel dicembre 1809.
Nel maggio 1814 aperto ancora una
volta e chiuso definitivamente nell'Ottobre 1816.
Con decreto del 24
Giugno 1806 Giuseppe Napoleone "re di Napoli e di Sicilia" abolisce
l'obbligo dell'affrancatura per le lettere di fuori regno.
L'abolizione della tassa postale per l'estero è limitata alla sola
terraferma dovendo la Sicilia pagare alle poste napoletane il tragitto
interno di grani 4 da Messina e 6 da Palermo, per lettere di un
foglio, ma data la situazione politica si reputa difficile la reale
applicazione di questo decreto alla Sicilia.
È da notare che il
precitato decreto contiene degli accenni alla funzionalità delle poste
napoletane e spagnole a Roma.
Con decreto di Gioacchino Napoleone "re
delle Due Sicilie" del 7 Maggio 1810 viene ripristinato l'obbligo
della affrancatura per le lettere estere "passando per la strada di
Roma" in ragione di grani 5, 8, 10 a seconda dalla provenienza della
lettera. E' in pratica una tassa postale per il tragitto fino a Roma.
Ancora il 14 marzo 1811 un nuovo decreto corregge le tasse per
l'estero che vengono abbassate a grani 5 per lettera semplice. Viene
altresì eliminato il balzello suppletivo delle distanze. Vi è una più
chiara denominazione della tassa da pagare: «3. le lettere, dirette
agli Stati al di la del Regno d'Italia, escluso l'impero francese,
pagheranno all'atto dell'immissione un diritto di affrancatura in
rimborso de' dritti di transito che la nostra amministrazione generale
delle poste dee pagare agli uffici di posta intermedij».
In questo
periodo di transizione, cessate le funzioni delle poste estere, le
Poste pontificie si inseriscono nel sistema dello smistamento delle
lettere estere, con qualche piccolo problema secondo la lettera
dell'11.6.1814 del cardinale Rusconi: «... (il) Direttore Generale
delle Poste del regno di Francia, é stato incaricato di spedire a
questo Generale Officio delle Poste Pontificie tutte le lettere della
Francia, e dei paesi esteri di transito per il regno di Francia.
Siccome fra queste lettere, annuncia il detto Sig.Direttore, vi
saranno quelle dirette al regno di Napoli, Sicilia, Malta, così si
troverebbe obbligato il Generale Officio delle Poste Pontificie di
passare le medesime all'Officio di Napoli, per farle pervenire al loro
destino.»
...«È ben vero che presentemente le corrispondenze per i
paesi esteri in transito per Roma provenienti da Napoli, come quelle
della Toscana dirette per Napoli, Sicilia, Malta, si ricevono e
rispettivamente si consegnano in ciascuno ordinario, come per una
segreta intelligenza tra i Ministri delle Poste, senza alcun foglio,
che lo autorizzi...». (nota 7)
Un altro problema lo pone il direttore della
posta di Genova. , «Devo poi far presente a Vostra Eccellenza, che
codesto Sig. Rusconi (funzionario della Posta pontificia) a cui ho
reclamato l'ammontare delle lettere procedenti dalla Francia e Spagna
per lo Stato Romano, e Napoli, che mi vengono tassate, e che io gli ho
rimesso e rimetto tuttavia, con sua lettera del 9 cadente mi rispose
che io potevo fare colla Francia un concambio delle lettere, che egli
mi rimetteva dirette per detti Regni, gravandole di tassa; io non ho
potuto fare a meno di replicargli, che lo Stato Romano è sempre stato
solito pagare ai rispettivi Uffici Esteri, che erano costa' stabiliti,
le lettere che vi distribuivano, senza prendere in compenso né codeste
lettere né quelle di Napoli, e che una tale misura mi pareva equa
tosto che il trasporto non si faceva da Corrieri pagati da Roma, e che
una tale ragione militava ancora al presente; aggiungo ora di più, che
codesto generale Ufficio percepisce la tassa sulle lettere del nostro
Stato, ed altri circonvicini, che gli invio nei pieghi del mio Ufficio
senza alcuna contribuzione, nel mentre che non sono
trasportate dai corrieri Romani; quindi non sarebbe priva di ragione
la domanda anche di una porzione di tassa.».
La risposta, sotto forma
di nota interna, è del seguente tenore:
«Alla Domanda del Sig.Direttore
delle Poste della Serenissima Repubblica di Genova fatta per il
pagamento dell'ammontare delle lettere procedenti dalla Francia e
Spagna, e dirette per lo Stato Pontificio, Napoli, Sicilia, Malta,...
rispose il provvisorio Soprintendente Generale delle Poste, che all'enunciato
debito doveva contrapporsi la spedizione di questo Generale Officio
che faceva, ed attualmente fa, della corrispondenza di Napoli,
Sicilia, Malta, per Francia e Spagna, fino a Firenze...
Se il
Direttore della Posta di Genova affaccia in suo favore il debito, che
le dà la Direzione delle Poste di Francia, il medesimo ha il diritto
di contrapporre a tal debito il porto della corrispondenza di Napoli,
Sicilia, Malta, Roma, fino a Genova, diritto che diminuirà
sensibilmente il suo debito con la posta di Francia.
Questo medesimo
diritto gli da motivo di rappresentare a quella Direzione di Francia
che non è giusto che la medesima tassi le lettere per lo Stato
Pontificio, Napoli, Sicilia, Malta, al saggio medesimo come le tassava
allora quando faceva il trasporto di tali lettere a sue spese per
intiero fino a Roma, non trasportandole ora che fino a Genova.».
«Molto meno sussiste... che il compenso dell'Officio Pontificio non
possa aver luogo, facendosi il trasporto da Firenze fino a Roma, ed il
ritorno da Roma a Firenze, delle anzidette corrispondenze di Napoli,
Sicilia, Malta, Roma da Corrieri che non gli appartengono, giacché
questo trasporto, e ritorno, si fa da questo generale Officio per metà
con quello di Firenze, per ciò che spetta al Porto... e per intero per
ciò che spetta al ricevimento e rinvio delle corrispondenze ...».(nota 8)
Questa corrispondenza porta ad alcune conclusioni.
1) La soppressione
delle Poste estere a Roma porta la conseguenza che Francia e Spagna
fanno giungere le loro lettere a Genova e chiedono un pagamento a peso
a queste poste. Le poste di Genova consegnano alle poste pontificie, a
Firenze, chiedendo una tariffa a peso che compensi la precedente
richiesta francese. Le poste pontificie consegnano alle poste
napoletane di Roma il pacco delle lettere di Napoli, Sicilia, Malta
chiedendo un compenso a peso. Allo stesso modo vengono trasportate le
lettere nascenti da Napoli, Sicilia, Malta e dirette in Francia.
2) Le
lettere venivano pagate dalle rispettive direzioni generale delle
Poste a scadenze fisse.
3) Erano ammesse le rese delle lettere indistribuite, da riportare a credito delle amministrazioni
interessate;
4) Dopo la soppressione delle
Poste estere a Roma quelle
Pontificie hanno la possibilità di sviluppare il proprio servizio di
Corrieri per collegare il Pontificio e il Napoletano con le altre
città d Italia. Le Poste pontificie proposero che le lettere
provenienti da Milano, e di tutta la Germania fossero trasportate a
cura dei Corrieri di Milano a Firenze, così come a Firenze arrivavano
le lettere di Francia e Spagna trasportate dai Corrieri di Genova; per
quelle di Venezia il trasbordo avveniva a Pesaro.
Da queste
destinazioni venivano trasportate da Corrieri delle Poste Pontificie.
E siamo all'epilogo.
Dopo lunghe e complesse trattative gli Stati si
arresero chiudendo a Roma gli uffici postali. Ma non sempre furono
nobili i motivi addotti per tale chiusura. Ecco la motivazione
principale secondo una nota del 4.11.1815 dell'ambasciatore francese a
Roma:
«Ma quando ho visto il sovrano di Roma, un Pontefice venerabile
per le sue virtù, per le lunghe sofferenze subite, limitarsi a
chiedere che egli potesse, nella sua capitale, far sorvegliare da
persone sicure i nemici che sono alle porte del suo palazzo, ho
creduto che avendo l'onore di rappresentare il Re, dovevo cedere ai
sentimenti nobili e generosi di cui Sua Maestà è stata sempre animata.
L'attenzione del Re non poteva essere che i cattivi approfittassero
della maggiore attività del suo servizio postale per far conoscere più
rapidamente le loro calunnie, far eseguire con maggior sicurezza i
loro complotti, far affrettare l'esecuzione delle loro perfidie.
Nella
relazione che inviai dissi quel che poco dopo accadde, che il Papa si
trovava seduto sopra un vulcano; che era circondato da nemici; che ne
aveva alle porte di Roma; e avrei potuto aggiungere che ne aveva nel
suo palazzo, nel sacro collegio.» (nota 9)
Dunque si chiedeva la chiusura
delle poste estere solo per controllare meglio le mosse, o gli
scritti, di quelli che erano considerati nemici personali del Papa,
insomma per questioni di potere, solamente di potere.
Non vi poteva
essere maggiore contrasto tra ingiusta motivazione per un giusto
provvedimento.
(1- Continua)
NOTE
(1) G. MIGLIAVACCA, Alle origini dell'Ufficio della Posta del regno di Napoli in Roma. Il Nuovo Corriere Filatelico n., Firenze.
(2) G. MISELLI, II Burattino veridico ovvero istruzione generale per chi viaggia, Bologna 1688.
(3) Per la Sicilia: «Le lettere che da questo Regno (di Sicilia) si mandano per Roma si affrancano per conto dell'Ufficio di Napoli (oltre il porto interno), e per il porto da Napoli a Roma, che spetta all'Ufficio di Napoli...».
Tariffa per la tassa in moneta di Sicilia. Manifesto a stampa pubblicato in Palermo nel 1725.
Per Napoli: «Lettere da Napoli e Regno per Roma si affrancano:...»
A. DI VITTORIO, Il Sistema postale nel mezzogiorno in età vicereale (1500-1734)
(4) V. MANCINI, Storia postale del regno delle due Sicilie, Molfetta 1986.
(5) V. MANCINI, op. cit., pag.38.
(6) Notificazione a stampa del 1741.
(7) C. FEDELE - M. GALLENGA, Per Servizio di Nostro Signore, Modena 1988.
(8) C. FEDELE - M. GALLENGA, Op. Cit..
(9) C. FEDELE - M. GALLENGA, Op. Cit..